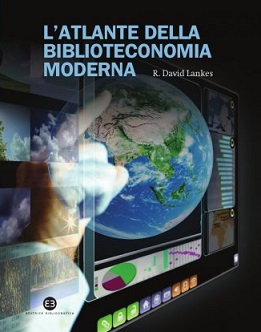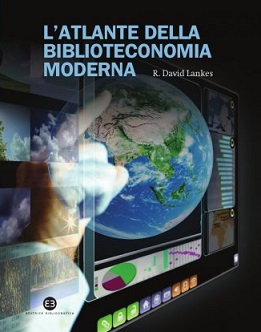 Se si dovessero indicare due tratti fondamentali del libro di R. David Lankes L’atlante della biblioteconomia moderna (ed. it.: Milano : Bibliografica, 2014), si potrebbero così individuare:
Se si dovessero indicare due tratti fondamentali del libro di R. David Lankes L’atlante della biblioteconomia moderna (ed. it.: Milano : Bibliografica, 2014), si potrebbero così individuare:
a) L’idea che la professione del bibliotecario debba essere definita in base a una “visione del mondo” e a una “missione” più che in relazione a funzioni.
b) L’interpretazione della professione attraverso la “teoria della conversazione”.
A mio parere, però, proprio a questi due tratti, che sembrano essere fondamentali per l’autore, si legano gli aspetti più deboli di questo libro, che ha comunque anche parti interessanti.
La “visione” e la “missione”
Secondo Lankes, i bibliotecari dovrebbero definire la loro professione non in base alle funzioni e ai compiti che svolgono e ai documenti di cui si occupano, ma in riferimento a una loro “visione del mondo” e a una loro “missione” che presenta in questo modo: “La missione dei bibliotecari consiste nel migliorare la società facilitando la creazione di conoscenza nelle comunità di riferimento” (p.23 – e poi ripetuta all’inizio di ogni capitolo).
Le funzioni e i documenti trattati, argomenta l’autore, possono mutare in relazione alle diverse richieste della comunità in cui la biblioteca opera. Lankes osserva anche che a chi definisce il lavoro del bibliotecario in base alla funzione di cercare dei documenti si potrebbe obiettare che lo fa anche Amazon, a chi si richiama alla funzione di reperire informazioni si potrebbe ribattere che lo fa anche Google (p.27). A dire il vero, però, questa obiezione potrebbe essere mossa anche alla sua enunciazione di “missione” dei bibliotecari. Quella di bibliotecario non è l’unica professione a porsi l’obiettivo di “facilitare la creazione di conoscenza”. Lo si potrebbe dire anche di Wikipedia, per proseguire i suoi paralleli, o di chi lavora in un museo archeologico o di storia naturale, per esempio.
Inoltre si dovrebbe osservare che la biblioteca non è legata necessariamente all’apprendimento. Una biblioteca di pubblica lettura offre anche letture di semplice svago. Lankes lo sa bene e mette le mani avanti: “soltanto libri di testo e manuali di tecnologia? Lungi da me”. Quindi aggiunge che “perfino un romanzo di Danielle Steel può dirci qualcosa su noi stessi (che cosa ci piace, che cosa speriamo, le vie di fuga che cerchiamo). Tutta la narrativa è radicale” (p.73). In questo modo, però, la definizione si fa ancora più vaga.
Lankes scrive, riferendosi ai bibliotecari: “siamo una nobile professione, non archiviamo libri e non cambiamo la cartuccia del toner: noi manteniamo un’infrastruttura per l’azione sociale” (p.127). Quel che l’autore intende è, si può pensare, che il lavoro dei bibliotecari ha un’importanza sociale che va al di là delle singole operazioni compiute durante la giornata. Questo è (o dovrebbe essere) vero, ma è altrettanto e anzi ancora più vero che se una biblioteca ha un’importanza sociale è anche grazie a chi mette il suo impegno anche in azioni non altisonanti come rimettere un libro sullo scaffale o cambiare la cartuccia della stampante quando è esaurita. Con un gioco di parole sulla frase di Lankes, potrei dire che noi bibliotecari non siamo una professione “nobile”: siamo un mestiere plebeo che si rivolge a tutti e che conosce il valore del lavoro quotidiano.
Come deve agire la biblioteca? Per Lankes “la risposta in sintesi è: chiedete alla vostra comunità” (p.81). Certamente raccogliere le richieste e le esigenze, espresse e inespresse, degli utenti (e dei potenziali utenti) non è cosa semplice e si potrebbe discutere sulle modalità, ma senza dubbio l’autore ha ragione nel sottolineare che è fondamentale tenere conto degli utenti. Lankes scrive però anche che “ad ogni modo ciò che si deve a tutti i costi evitare sono i servizi che non corrispondono alla missione dei bibliotecari” (p.103). Al di là del fatto che la sua definizione di “missione dei bibliotecari” non appaia del tutto convincente (e, più in generale, ci si può chiedere se si debba dare tanta importanza all’enunciare una “missione”), Lankes ha ragione nel dire che le richieste alla biblioteca devono essere coerenti con ciò che è la biblioteca. La richiesta, per esempio, di riparare le buche delle strade, pur se legittima, dovrà essere indirizzata ad altri. Lankes prosegue scrivendo in modo del tutto corretto: “Ci sono dei confini per tutte le professioni, e anche se questi limiti non sono più identificabili con l’espressione “ogni volta che i libri possono essere utili”, ci sono ancora” (p.103).
Si può pensare a questa corretta delimitazione quando Lankes scrive: “Se la nostra comunità ha bisogno di un laboratorio, mettiamo in piedi un laboratorio, non una collezione di libri che parlano di costruire laboratori” (p.50). Se la comunità sente tale necessità, la richiesta è legittima, come lo sarebbe quello di avere per esempio una farmacia in paese o un campetto da calcio per i ragazzi. Resta da vedere se la professionalità del bibliotecario è la più adatta per realizzarlo e gestirlo. Un laboratorio di falegnameria sarà gestito da un falegname meglio di quanto potrebbe fare un bibliotecario, così come, si spera, un bibliotecario gestirà una biblioteca meglio di un falegname.
Considerazioni di questo tipo sono importanti anche a proposito di un’idea piuttosto in voga di biblioteca “sociale”. Ne troviamo qualche traccia anche nel libro di Lankes, che comunque non insiste molto sul tema. L’autore scrive che il “valore” della biblioteca si può trovare anche “nell’aiutare qualcuno a trovare lavoro, nel consigliare ad una moglie che ha subito abusi di consultare i servizi sociali per salvare la sua vita” (p.13; v.a. p.79). Per quanto riguarda il primo caso, la biblioteca ha il compito di trovare documenti e informazioni che soddisfino le richieste dei suoi utenti, quindi certamente può aiutare in questo modo anche chi sia alla ricerca di un lavoro. Per fare un esempio banale, può procurare un libro con esempi di test per chi intende provare un concorso pubblico. Sulla questione lavorativa, però, è da supporre che un assistente sociale sia più competente di un bibliotecario. Il secondo caso è molto delicato e Lankes giustamente reputa che la cosa giusta da fare sia suggerire alla donna di rivolgersi a chi ha le competenze necessarie (improvvisarsi “esperti” in casi come questi, pur se animati magari da buona volontà, può causare più guai che vantaggi). Che un bibliotecario che si trovi di fronte una situazione del genere faccia bene a dare un tale consiglio è fuori di dubbio, ma dobbiamo considerarlo un “valore” della biblioteca o della professione di bibliotecario? Non è più sensato pensare che sia un dovere morale che chiunque dovrebbe avere indipendentemente dalla professione? L’impiegato dell’anagrafe o la parrucchiera non dovrebbero forse fare lo stesso?
 La “teoria della conversazione”
La “teoria della conversazione”
Nel libro, Lankes pone come fondamento del suo discorso la “teoria della conversazione” di Gordon Pask. Cita inoltre come riferimenti la “teoria della motivazione”, la sense-making theory, il postmodernismo. L’autore ritiene addirittura che “tutti questi approcci combinati tra loro richiedono un nuovo patto sociale tra bibliotecari e coloro che usufruiscono del loro servizio” (p.28).
Un approccio interdisciplinare può certamente rivelarsi utile in diversi casi. Se, usando le idee sopra citate, si offrono spunti interessanti per la biblioteconomia, li si può senza dubbio valutare. Altra cosa è, però, affermare che la teoria della conversazione o le idee postmoderniste debbano necessariamente essere parte della biblioteconomia o addirittura esserne un fondamento tanto da richiedere persino “un nuovo patto sociale”: su questo non si può essere d’accordo.
Rifacendosi alle idee sopra citate, Lankes sostiene che ogni decisione deve essere un accordo risultante da conversazioni e applica tale schema anche alla ricerca delle informazioni in biblioteca, con esiti non sempre felici. L’autore scrive che “i bibliotecari non dicono di poter distinguere le “buone informazioni” da quelle “cattive”” e che “cosa è valido o no, cosa è credibile e cosa no, sono tutte decisioni dei membri (*) e delle comunità” (p.89). Non è affatto così.
(*) Lankes preferisce il termine “membri” a quelli normalmente usati per indicare chi usufruisce dei servizi delle biblioteche, come “utenti” o “lettori” (cfr p.64). La scelta ha un suo senso, sottolineando che le persone non si rivolgono alla biblioteca pubblica come clienti di un’attività di proprietà e gestione altrui, ma come a qualcosa che è anche loro, di cui fanno parte. Alla fine, comunque, non mi pare che ci sia un così grande bisogno di cambiare la terminologia più usata. La mia definizione preferita sarebbe “lettori” perché indica la specificità della biblioteca: non “utenti” o “membri” di un generico servizio, ma “lettori”. E’ anche vero che chi frequenta la biblioteca oltre che “leggere” può anche “ascoltare” (un audiolibro, un cd musicale, la storia raccontata ai bambini della scuola, le informazioni riferite dal bibliotecario), “guardare” (il dvd, ma anche le illustrazioni dei libri), “toccare” (i libri tattili per i ragazzi, i testi in braille) e persino “odorare” (“mi dai quel libro di Geronimo Stilton che quando strofini la pagina si sentono gli odori?”).
Questa e altre idee in voga negli ambienti postmodernisti erano state il bersaglio di una beffa messa in atto nel 1996 dal fisico Alan Sokal che aveva scritto un articolo basato su di esse e volutamente privo di senso e lo aveva inviato a una rivista cha accoglieva tali idee. L’articolo fu pubblicato e Sokal rivelò che si trattava appunto di una burla fatta per mostrare quanto quelle concezioni fossero slegate dalla realtà. In un articolo in cui commentava il suo esperimento, Sokal scrisse: “chiunque creda che le leggi fisiche siano solo convenzioni sociali è invitato a provare a trasgredire a quelle convenzioni dalla finestra del mio appartamento (abito al ventunesimo piano)” (*).
(*) Alan Sokal, A physicist experiments with cultural studies, “Lingua Franca”, 1996: versione html – versione pdf.
La validità di un’affermazione non è una convenzione decisa dagli utenti. Non molto tempo fa, per esempio, nelle nostre biblioteche c’era una fila di prenotazioni per il libro La dieta del dottor Mozzi, ma, nonostante il successo riscosso presso i nostri lettori, le informazioni contenute in questo testo di Pietro Mozzi su un presunto legame tra alimentazione e gruppi sanguigni sono prive di validità e credibilità scientifica.
A sostegno dell’idea che la validità e credibilità dipenda da quel che decidono gli utenti, Lankes porta come esempio il sito del Ku Klux Klan, dicendo che non è certamente una buona risorsa per un utente che cerca un gruppo per attività ricreative, ma lo è per qualcuno che sta facendo un lavoro di ricerca sul razzismo (p.89). L’esempio non è però convincente perché il fatto che in un caso sia una fonte da scartare e nell’altro una fonte utile dipende dall’utilizzo che ne viene fatto e certamente lo stesso Lankes presuppone che chi usa quel sito per la ricerca sa comunque che è una fonte “cattiva”. Se si presentasse un razzista che ritenesse quelle idee una buona cosa, questo non cambierebbe il giudizio. In questo caso la questione è principalmente etica (e come tale è presentata anche dall’autore), per quanto le idee di superiorità razziale siano anche una sciocchezza dal punto di vista scientifico. L’autore parla però anche di “cosa è credibile e cosa no”, il che sembra portare il discorso sulla validità scientifica e storica dell’affermazione.
Lankes scrive che “guadagniamo fiducia poiché suggeriamo risorse varie che mostrano diverse prospettive e facilitiamo i membri a fare scelte consapevoli. L’approccio alternativo di predeterminare buone o cattive risorse è invece autoritario” (p.89). Ancora una volta, non si può essere d’accordo. Al lettore interessato ad approfondire l’argomento dell’evoluzione umana potremmo proporre diversi validi libri (o anche dvd) che potrebbero anche contenere idee diverse in questo o quel punto. Se, però, presentiamo come risorsa con pari validità un libro in cui si dice che l’evoluzione dell’uomo è dovuta a un intervento di ingegneria genetica effettuato da creature extraterrestri (per chi già non lo sapesse: ebbene sì, esistono tali libri), non credo che “guadagniamo fiducia”. Anzi, un bibliotecario che suggerisse un testo del genere per conoscere l’evoluzione umana potrebbe a ragione essere considerato, al contrario, inaffidabile. Riprendendo l’argomento di Lankes sopra rammentato, il libro con gli alieni creatori dell’umanità potrà essere utile a qualcuno che voglia studiare le pseudoscienze, ma l’utilità a tal fine non implica una credibilità.
E’ possibile che Lankes si sia fatto prendere un po’ troppo la mano dalle idee in cui ha voluto inquadrare le sue argomentazioni. Più avanti, in effetti, dopo aver detto che “bisogna ascoltare tutte le voci” (impresa non semplice, peraltro: ci sono una valanga di voci, più o meno sensate, in circolazione), aggiunge che si deve però anche “essere rigorosi nel loro esame e nella loro diffusione” (p.115). Ovvero, in altre parole, giudicare “buona” o “cattiva” questa o quella risorsa.
Creatività e partecipazione
Del tutto condivisibile è l’invito di Lankes a favorire un approccio creativo e sperimentale nelle biblioteche (“create un ambiente sicuro per il rischio e la sperimentazione, lasciate al personale tempo per sperimentare, premiate i tentativi e i fallimenti come i successi” – p.120). L’autore sottolinea anche l’importanza delle iniziative nate dalla partecipazione. A questo proposito cita fa l’esempio di iniziative di cooperazione per il reference digitale: “Molte di queste associazioni o reti erano informali, molte erano addirittura nate come scambi personali tra bibliotecari e sono cresciute più come servizi tra pari che come un insieme di servizi strutturati secondo un regolamento formale definito” (p.147).
Lankes ha il merito di porre, sia pure quasi di sfuggita, una questione che molto raramente viene discussa ed è, invece, assai importante: “Perché mai la comunità bibliotecaria è così gerarchica e frammentata?” (p.147)
Le bibioteche presenti su un’area possono evidentemente offrire un servizio migliore ai loro utenti se si associano per formare una rete. Questa scelta è indubbiamente vantaggiosa (e molto). Chi si unisce in una rete bibliotecaria dovrebbe però stare molto attento a evitare il pericolo che la rete, invece di essere al servizio delle biblioteche, si ponga sopra le biblioteche. Le decisioni non dovrebbero essere calate o, peggio, imposte dall’alto, ma nascere dalla condivisione tra le biblioteche. Ogni aspetto gerarchico dovrebbe essere subito eliminato, favorendo invece la partecipazione e la condivisione. Una rete di biblioteche offre anche l’occasione di valorizzare le competenze specifiche dei singoli bibliotecari a vantaggio di tutte le biblioteche.
Il tema della partecipazione può essere esteso anche agli utenti della biblioteca. Certamente Lankes esprime una valida idea quando parla della “comunità come collezione”, ovvero coinvolgere gli utenti e le loro competenze nell’attività della biblioteca, “per rispondere alle domande e coltivare le collezioni” (p.146). “Non potrete mai conoscere tutto, ma dovreste riuscire a trovare chi sa”, scrive l’autore rivolgendosi ai bibliotecari, suggerendo loro anche di “costruire gruppi ad hoc e permanenti di esperti di tutti i tipi” (p.154).
Cataloghi e catalogazione
L’autore è del parere che “piuttosto che catalogare manufatti e presumere che questi siano a se stanti, dovremmo elaborare sistemi che si concentrano sulle loro relazioni” (p.132). Lankes porta l’esempio di Amazon che, quando mostra un documento, ne segnala altri simili. Queste funzioni del tipo “more like this” (nell’immagine sotto il “frequently bought together” che compare ora su Amazon.com per l’edizione inglese del libro di Lankes) sono per l’autore centrali: “Queste tre parole rappresentano qualcosa di paragonabile a un Santo Graal nell’ambito dell’organizzazione dell’informazione” (p.133).

Ovviamente già ci sono nei cataloghi relazioni tra i libri (per esempio, le intestazioni permettono di trovare libri dello stesso autore, i soggetti consentono di scovarne con il medesimo argomento) e sono più precise ed efficaci delle funzioni di ricerca e dei suggerimenti di documenti simili dei siti commerciali. Lo stesso Lankes riconosce che con i nostri cataloghi i bibliotecari se la cavano molto bene, ma aggiunge che gli utenti invece “ne escono male” (p.41) e suggerisce, con toni forse un po’ troppo drastici, un totale ripensamento dei “sistemi di recupero e rappresentazione della conoscenza” per gli utenti (*).
(*) “E’ giunto il momento di smetterla con le conversazioni sui cataloghi della “prossima generazione” e di assicurarci che questa sia l’ultima generazione di cataloghi ad uso pubblico. Dobbiamo separare i sistemi inventariali ad uso dei bibliotecari dai sistemi di recupero e rappresentazione della conoscenza di cui i membri della biblioteca hanno disperatamente bisogno.” (p.136)
In ogni caso, quello delle relazioni tra i documenti è sicuramente un argomento importante. Per fare un solo esempio, spesso capita che un lettore voglia sapere quali sono gli altri libri di quel determinato autore nei quali è protagonista il tale investigatore e in che ordine sono. Almeno per gli autori più noti, in genere possiamo trovare l’elenco consultando Wikipedia, ma non sarebbe male se queste informazioni fossero incluse nel catalogo. E’ chiaro che ogni arricchimento informativo di questo tipo comporta un maggior impegno nella catalogazione, ma con una buona gestione della catalogazione partecipata tra i bibliotecari (anche nella catalogazione sarebbe bene puntare sulla partecipazione invece che sulla centralizzazione) è senza dubbio possibile fare dei validi passi.
 Al convegno delle Stelline del 2018 si è parlato di “digital reference, information literacy, e-learning” (*). In diverse relazioni si è fatto riferimento, in modo più o meno ampio, al tema della valutazione critica delle informazioni.
Al convegno delle Stelline del 2018 si è parlato di “digital reference, information literacy, e-learning” (*). In diverse relazioni si è fatto riferimento, in modo più o meno ampio, al tema della valutazione critica delle informazioni.